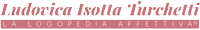M come Mi ricordo quando
Un capitolo tratto dal mio ebook “LA MIA LOGOPEDIA”
La mia università di vent’anni fa era una favola.
Era una situazione intermedia tra la scuola superiore ed un intervento a cuore aperto in ospedale.
Era a numero chiuso, ogni anno potevano subentrare venti allieve, con selezione, esisteva un test d’ingresso, io feci un buon punteggio ed entrai, senza stupore, era già la mia strada.
Il primo anno era fatto di un tirocinio passivo senza fine, ci si presentava alle nove massimo e la giornata poteva finire anche dodici ore dopo, con forze alterne si seguivano le terapie dell’allieva vecchia, quella dell’ultimo anno che poi si sarebbe laureata.
Giornate infinite, fatte di attenzione, sudore, tensione e risate, quante risate.
Vivevamo in ospedale e le risate si aprivano in sequenza, nei corridoi, al nostro tavolo tondo, in bagno, in segreteria, ovunque. Avevamo un bel gruppo, ci si ritrovava a fumare, a parlare, ad aver paura e ad aver rispetto.
Rispetto di una serie di situazioni spesso più grandi di noi, piccoli ragazzini ancora assetati di risate, sigarette, bei pantaloni su una caviglia spesso gonfia e rossa.
Eravamo circondati da una serie di logopediste strutturate, libere di assistere alle sedute di ognuna, ma obbligate a rimirare quelle della più somma e gigante, la nostra docente indiscussa, quella più brava, quella fatta di roccia e cotone bello e duro, quella che guardava e uccideva, piano, ma bene.
La sua stanza era una grande carneficina, lei arrivava prestissimo, era piccolina in realtà, ma era talmente maestosa e importante che riempiva la stanza in altezza. Si metteva il camice e si sedeva.
Chiedeva del primo controllo e cercava l’allieva interessata che ovviamente non aveva chiuso occhio tutta la notte. Durante il controllo lei verificava che tutto ciò che aveva programmato durante l’ultimo incontro con il paziente fosse stato svolto correttamente. Se il paziente vacillava, non sapeva, nicchiava o addirittura si perdeva era la fine.
L’allieva cominciava a perdere i tratti somatici, mentre la mia docente cominciava ad assumerne altri, di nuovi, di mostruosi, e io la amavo. Amavo le sue ire, le sue cariche, i suoi sbalzi, era tutta passione, tutta energia viola.
La stanza poteva essere tracimante di sessanta allieve, accatastate, schiacciate, sudate e spaventate.
Tutte insieme assistevamo a ciò che di più bello potessimo osservare: la linearità, un fluido continuo e colorato che non si apriva mai, che non vacillava mai, scorrevole, buono e alto.
Lei sul serio non sbagliava mai, teneva al suo fianco il paziente che per lei rappresentava un’equazione, un conto, un’operazione da risolvere, non che non scoprisse il sentimento, ma la sua priorità era la risoluzione del caso. Per lei arrivava subito, come apriva la bocca, una corrente le entrava dentro e parlava per lei.
Era massacrante per alcune scoprire che non si ricordava il loro nome, sapevamo che memorizzava all’istante solo i nomi delle allieve che stimava, che pensava potessero diventare delle brave logopediste.
Il primo controllo era il più importante, quei quindici minuti potevano determinare l’idea che lei si sarebbe fatta, difficile poi farle cambiare idea.
Dava i casi più difficili alle cinque, al massimo sei allieve per anno che stimava veramente, le altre erano fuori, morte, incalcolate, zombie che sapevano che mai avrebbero avuto una seconda occasione, come se una scritta rossa fosforescente scorresse loro sulla fronte, oppure uno stemma inciso sul taschino del camice, da rabbrividire.
Il segreto era essere naturalmente intelligenti, sveglie, disinvolte, spigliate e soprattutto sempre pronte alla fatica.
Lei amava scoprire l’allieva onnipresente, doveva essere dappertutto, in ospedale, nel suo studio privato e anche a casa sua. Succedeva che si volesse avventurare in ricerche, esperimenti e nuovi studi e chiedesse a qualcuna di aiutarla la sera a casa sua.
Così ci si apriva il mondo in due, il mondo era bello, colorato, buono e servizievole, eravamo utili, vive e anche belle.
Era instancabile, aveva negli occhi sempre la stessa luce, lo stesso valore e lo stesso piglio, a volte però sorrideva, rideva anche e ridevamo anche noi, come prese da un terremoto di delirio, senza sapere il perché. Quando all’improvviso ci rivolgeva lo sguardo e parlava tremavamo e ci sentivamo pronte per qualsiasi richiesta, o buona o cattiva. Non mi ha mai sgridato e io l’ho sempre adorata, l’adoro ancora, devo a lei la logopedista che sono, quando lei ha smesso di insegnare all’università è mancata la vera scienza, le giuste cose, i giusti equilibri.
I bambini la amavano, oppure forse a volte la temevano, aveva un carisma che non ho più incontrato nella mia vita in nessuno. So che ora è molto anziana, ovviamente non lavora più, so che ha sofferto molto, vorrei parlarle, dirle che il suo viso mi torna a galla almeno una volta al giorno, davanti a quel signore anziano o a quel bambino svogliato.
Ma ho paura che non si ricordi di me, mi ha insegnato anche l’umiltà.